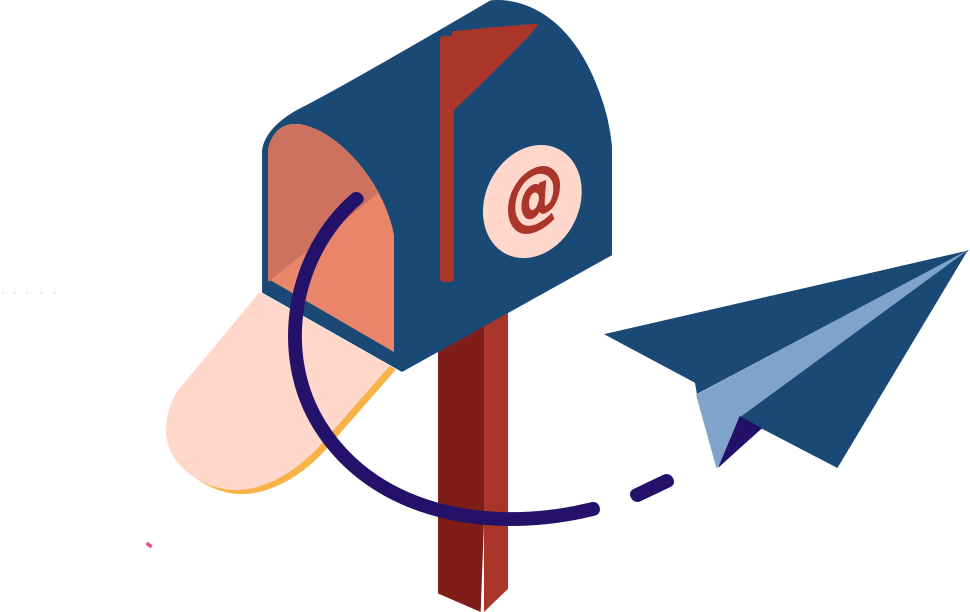I princìpi del risultato e di buona fede non possono tradursi nell’imposizione all’operatore privato di un onere tendente a superare il vizio del provvedimento prima dello svolgimento della gara

L’aggiudicazione ed i provvedimenti ad essa connessi sono stati impugnati dall’appellante, con particolare riferimento alla mancata previsione nelle norme di gara dei criteri ambientali minimi.
In primo grado il giudice, valorizzando il principio di fiducia, aveva respinto il ricorso sostenendo che parte ricorrente, sebbene contestasse l’aggiudicazione avesse però formulato un’offerta ispirata alla sostenibilità ambientale. E dunque avesse in qualche modo “sanato” la lex specialis carente del richiamo ai criteri ambientali minimi.
Consiglio di Stato, Sez. III, 08/10/2025, n. 7898 accoglie l’appello:
Ritiene il Collegio che non possa condividersi la conclusione del primo giudice secondo la quale la condotta della ricorrente avrebbe in qualche modo “sanato” la genericità (rectius: invalidità per carenza di un elemento normativamente necessario) del richiamo della lex specialis alla disciplina dei criteri ambientali: “Viceversa, appare cha la formulazione “aperta” ed elastica dell’art. 24 del disciplinare (dettante la prescrizione di “adottare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le attività di manutenzione dettati dal Ministero dell’Ambiente, con particolare riferimento, oltre agli aspetti energetici oggetto di affidamento, anche all’approvvigionamento e all’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita dell’opera, alla gestione del ciclo dei rifiuti, ecc., in linea con le normative europee, nazionali e locali, adeguando di conseguenza il Servizio da assumere”) sia stata ben intesa e applicata dalla ricorrente, che con la propria offerta ha “riempito” i supposti vuoti della prescrizione medesima. (….) Pertanto, alla stregua del principio della fiducia possono essere valutati e risolti i dubbi sulla legittimità della disciplina, in tutte le ipotesi di insorgenza di aspetti critici che, a ben vedere, non si sostanziano in vizi che abbiano avuto incidenza sostanziale e lesiva della posizione soggettiva della parte, cosicché la legge di gara, congiunta all’applicazione che ne hanno dato le parti, reca in sé l’autodisciplina del caso concreto e consente di risolvere in tal modo i dubbi interpretativi”.
Tale conclusione avrebbe potuto avere un astratto rilievo, in tesi, ove il contributo dell’offerta contrattuale integrativa avesse sanato la (illegittima) disciplina di gara senza pregiudizio per l’interesse della ricorrente.
Ma non si vede come possa attribuirsi a tale offerta un rilievo tale da escludere l’illegittimità della censurata lex specialis, una volta che l’offerta risultata aggiudicataria sia altra, e che dunque l’offerente sia stata lesa dall’esito della (illegittima) procedura.
12. Ancora una volta il richiamo al principio di fiducia, ove mai rilevante (in senso “sanante”) avuto riguardo alla disciplina del descritto modello di tutela della sostenibilità ambientale in materia di contratti pubblici, non può comunque avere rilievo esimente rispetto ad una difformità del provvedimento dal relativo paradigma normativo avuto riguardo non alla mera divaricazione formale, ma proprio alla tutela – sul piano sostanziale – degli interessi protetti dalla disposizione di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 50 del 2016 (e dell’art. 57 del d. lgs. n. 36 del 2023).
A ben vedere il riferimento, nella sentenza gravata, al principio della fiducia anche in relazione alla dialettica fra la censura di violazione dei c.a.m. e l’avvenuta presentazione di un’offerta ecosostenibile, utilizza in realtà argomenti logici che riecheggiano piuttosto il principio di buona fede (che ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, e dell’art. 5 del d. lgs. n. 36 del 2023, impegna entrambe le parti del rapporto amministrativo), e conseguentemente un possibile abuso del diritto e del processo (pur senza giungere a conseguenze su questo terreno, ma limitando il supporto argomentativo sul piano delle regole di validità, in punto di affermazione della legittimità di un provvedimento così contestato, per respingere il ricorso nel merito).
13. Al tema della buona fede dell’operatore economico fa del resto riferimento anche la già richiamata – ad altri fini – sentenza n. 6651 del 2025 della V Sezione di questo Consiglio di Stato, invocata dall’Azienda appellata: “Il principio del risultato, letto in combinato disposto con quello della buona fede di cui all’art. 5, si traduce per l’operatore economico nella individuazione della soglia di sforzo esigibile per comprendere l’interesse cui la commessa è preordinata e in una maggiore responsabilizzazione nel segnalare tempestivamente alla S.A. l’impossibilità o la difficoltà di comprendere tale finalità e di corrispondervi con un’offerta consapevole e conforme alla lex di gara senza far proseguire la procedura e farla giungere al termine per poi contestarla sulla base di vizi integralmente afferenti alla lex di gara e come tali incidenti sulla stessa possibilità di formulare un’offerta consapevole”.
In argomento deve anzitutto escludersi (per le ragioni sopra richiamate) una automatica ridondanza dei “vizi integralmente afferenti alla lex di gara” sulla “stessa possibilità di formulare un’offerta consapevole” (che vanificherebbe e smentirebbe l’articolato sforzo ricostruttivo della sentenza n. 4/2018 dell’Adunanza Plenaria, che distingue e non sovrappone i due elementi, e che pone un diverso rapporto regola/eccezione).
Inoltre, la valorizzazione del principio del risultato deve comunque tener conto di quanto ribadito da ultimo in giurisprudenza nel senso che “pur se l’art. 1 cit. fa riferimento al “risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione”, non può certo ritenersi che il principio sia diretto a raggiungere un affidamento e una esecuzione del contratto “quali che siano”. Al contrario, l’affidamento della commessa e l’esecuzione del contratto devono essere funzionali al raggiungimento degli interessi pubblici che la commessa mira a soddisfare e il principio del risultato deve senz’altro essere inteso in tale ottica” (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6337/2025; nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4701/2024: “Non trova dunque giuridico fondamento la tesi per cui la positivizzazione in materia contrattuale del principio del risultato avrebbe sancito il primato logico dell’approvvigionamento: non foss’altro perché tale principio è strettamente correlato a (e condizionato da) quello della fiducia, e dunque si differenza dalla logica del risultato “statico” di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 per rivolgersi invece alla effettività della tutela degli interessi di natura superindividuale la cui cura è affidata all’amministrazione, fra i quali quello della tutela ambientale assume un ruolo decisamente primario alla luce sia della richiamata Direttiva 2014/24/UE, che del riformato art. 9 della Costituzione”).
14. In ogni caso ad avviso del Collegio la disciplina dei princìpi del risultato e di buona fede non può comunque tradursi nell’imposizione all’operatore privato di un onere tendente a superare il vizio del provvedimento prima dello svolgimento della gara, pena l’irricevibilità o inammissibilità (o infondatezza) del ricorso giurisdizionale (o di specifiche censure) avverso gli atti terminali della gara stessa.
Una simile affermazione sarebbe, a tacer d’altro, contraria all’effettività della tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
D’altra parte la ricordata sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 4 del 2018 ha chiarito che la tutela giurisdizionale avverso l’impugnazione di bandi illegittimi si si esercita, di regola, solo “unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato”; solo in via di eccezione la sentenza ha affermato l’onere di immediata impugnazione di clausole che abbiano effetto escludente (anche indirettamente, in termini di formulazione dell’offerta).
Tale conclusione poggia sulla disciplina, anche costituzionale (si vedano, in particolare. i punti 16.8., 18.7.1. e 19.1.2. della motivazione della sentenza appena richiamata) e comunitaria (Corte di Giustizia dell’U.E., sentenza 5 aprile 2016 in causa C-689/13), della tutela processuale amministrativa avverso i bandi di gara illegittimi: essa, pertanto, non può essere alterata dalla disciplina “di principio” del (procedimento di evidenza pubblica, e del) rapporto negoziale, ammesso che a quest’ultima possa ricondursi il significato di imporre uno sforzo esigibile in tal senso.
15. Sotto tale profilo si consideri che questa Sezione, nella sentenza n. 2866/2024, ha affermato nella medesima materia che “l’obbligo di agire secondo buona fede (art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241: ora declinato nella materia contrattuale dall’art. 5 del citato d. lgs. n. 36 del 2023), configura – come è stato osservato in dottrina – un “rapporto di tipo orizzontale tra cittadini e pubblica amministrazione”, che comporta – oltre a dei precisi doveri per l’amministrazione – anche una più marcata responsabilizzazione dei primi in seno al procedimento, il che nel caso di specie si traduce nella individuazione della soglia di sforzo esigibile dall’operatore economico per comprendere l’interesse cui la commessa è preordinata”.
Un tale sforzo non può tuttavia tradursi nell’adozione di comportamenti potenzialmente lesivi per la stessa parte (o comunque contrari al suo interesse): la segnalazione dell’illegittimità o incompletezza del bando con riferimento ad un determinato aspetto di disciplina può infatti danneggiare gli interessi del singolo operatore economico; l’amministrazione è attributaria della cura dell’interesse pubblico portato dalla disciplina che si assume violata, e come tale è responsabilizzata in relazione all’adozione di una legge di gara conforme a tale disciplina.
In ogni caso una simile soluzione sottrarrebbe all’operatore economico, per effetto dell’iniziativa assunta, un possibile motivo di impugnazione, stabilendo così una decadenza in via interpretativa.
Essa, inoltre, costringerebbe gli interessati ad impugnare il bando indipendentemente dall’esito della gara (e, dunque, dalla concreta lesività del vizio).
Non senza ragione, pertanto, la più volte citata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018 aveva chiarito che “l’effetto pressochè certo dell’abbandono del criterio tradizionale è quello dell’(ulteriore) incremento del contenzioso: quantomeno a legislazione vigente, i possibili vantaggi sembrano del tutto ipotetici”.
Neppure sotto tale profilo, dunque, è dato cogliere una infondatezza (o inammissibilità) della pretesa della parte ricorrente, posto che il ricorso di primo grado – come già specificato – non aveva riguardo all’impossibilità di formulare l’offerta, ma alla illegittimità della legge di gara per mancato inserimento nella stessa dei criteri ambientali minimi.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 08/10/2025 di Roberto Donati
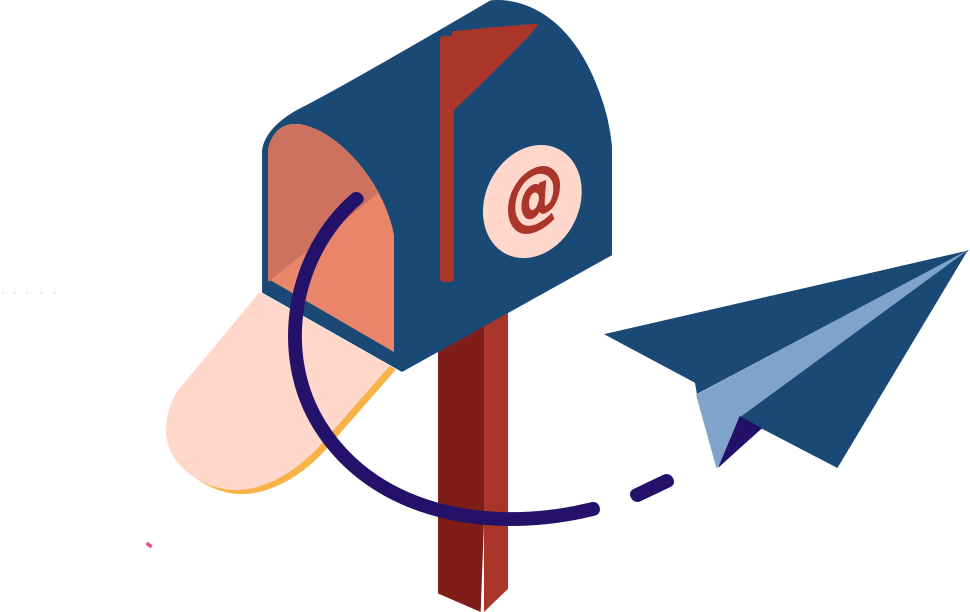
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Iscriviti Ora