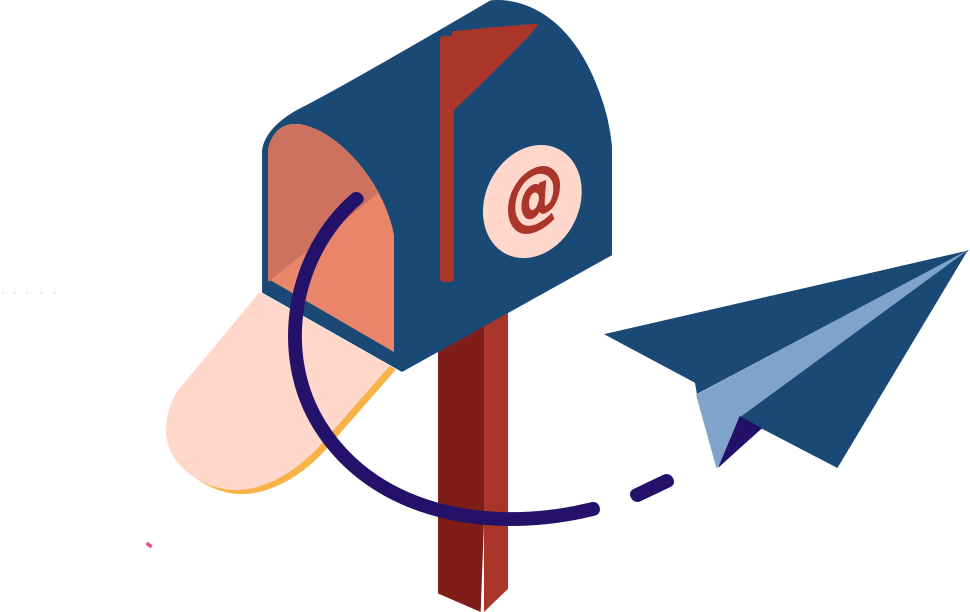Il PEF rappresenta il fulcro della proposta di finanza di progetto

Il PEF rappresenta il fulcro della proposta di finanza di progetto, in quanto elemento preordinato a consentire di valutare la proposta progettuale per la sua adeguatezza e per l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della futura concessione, nonché di misurare la validità dell’iniziativa economica.
Questo quanto ribadito da Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 24/10/2025, n. 2970:
Ebbene, vi è ragione di ritenere, ad avviso di questo Collegio, che alla data di entrata in vigore di tali disposizioni il procedimento di finanza di progetto per cui è causa non fosse già “in corso”, atteso che la presentazione del PEF costituisce un elemento che qualifica la proposta progettuale, rappresentandone un requisito che ne integra, indefettibilmente, la correlata validità.
Tale assunto deve trarsi, in prima battuta, dall’analisi letterale del testo normativo di riferimento, ossia il vigente art. 193, comma 3, del D.lgs. 36/2023, il quale, nel declinare gli elementi che ciascuna proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi “contiene”, richiama espressamente, oltre al “progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l’articolo 6-bis dell’allegato I.7.”, a “una bozza di convenzione” e alla “specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l’indicazione dei requisiti del promotore”, anche il “Il piano economico-finanziario”, il quale “comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno”.
Tale disposizione, peraltro, si colloca su un piano di continuità:
(i) con quanto previsto dall’art. 193, comma 1, del D.lgs. 36/2023, nella formulazione anteriore alle modifiche e integrazioni apportate dal D.lgs. 209/2024, ove veniva espressamente previsto che “Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”;
(ii) con l’antecedente previsione di cui all’art. 183, comma 9, del D.lgs. 50/2016, il quale stabiliva che “Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile”.
La valorizzazione, per via legislativa, dello strumento del PEF quale requisito qualificante la proposta progettuale in materia di project financing è coerente, del resto, con il ruolo di primaria importanza che esso viene ad assumere, quale elemento preordinato a consentire di valutare la proposta progettuale per la sua adeguatezza e per l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della futura concessione, nonché di misurare la validità dell’iniziativa economica.
Come tale, quindi, esso rappresenta un elemento significativo della proposta progettuale e ne integra a pieno titolo la validità, “…di cui vale ad illustrare, valorizzare, corroborare e giustificare la complessiva sostenibilità tractu temporis: pur non sostituendosi o sovrapponendosi ad essa, in sostanza, ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, al fine di provare che l’impresa andrà prospetticamente a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività” (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2024, n. 8437; Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6015; Cons. Stato, Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2018, n. 2214; Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2013, n. 4760; Cons. Stato, sez. III, 22 novembre 2011, n. 6144; Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2010, n. 653).
Detto altrimenti, il PEF rappresenta il fulcro della proposta progettuale, atteso che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, esso costituisce “…un elemento essenziale dell’offerta alla luce dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, con la conseguenza che la mancanza del piano o l’omessa asseverazione da parte di soggetto abilitato costituisce vizio essenziale dell’offerta, non sanabile col soccorso istruttorio stante l’art. 83, comma 9, del medesimo decreto. Peraltro, trattandosi di un documento caratterizzato da una particolare qualificazione in materia finanziaria nonché dalla terzietà del soggetto da cui promana, non è ammissibile che alla sua mancanza possa sopperire la valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice, la quale si pone e, dunque, deve essere correttamente intesa in termini di mera attività aggiuntiva e non certo sostitutiva dell’asseverazione in argomento” (Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 14 dicembre 2023; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 febbraio 2020, n. 611).
Tale documento, ancor più specificatamente, “…dà modo all’amministrazione, che ha invitato ad offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto: sicché un vizio intrinseco del PEF – come quello di un riferimento temporale diverso dallo stabilito – si riflette fatalmente sulla qualità dell’offerta medesima e la inficia. Questa conclusione può essere confermata dalla considerazione che […] nel corso dell’esercizio della concessione, l’eventuale alterazione degli indicatori del PEF derivante da circostanze sopravvenute può determinare la modifica di elementi essenziali della concessione, quali l’entità del canone o la durata del rapporto; […]” (Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2018, n. 2214).
Il provvedimento concessorio da adottarsi al termine della procedura per cui è causa, per sua natura, si qualifica, in particolare, “…per il trasferimento del rischio operativo dal concedente al concessionario e, in tale contesto, il PEF ha la funzione di garantire l’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa e la corretta allocazione dei rischi lungo tutto l’arco temporale della gestione della concessione” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 17 giugno 2025, n. 1060).
Ne è conseguenza che la mancata presentazione del PEF non possa configurare una mera irregolarità formale o un errore materiale sanabile, a livello generale, mediante il soccorso istruttorio, il quale – anche nell’ampliato perimetro che a tale strumento viene riconosciuto dal D.lgs. 36/2023 – può consentire la sanatoria di difformità e carenze formali facilmente riconoscibili, ma non può supplire a sostanziali carenze dell’offerta o, come nel caso del project financing, della proposta progettuale.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 24/10/2025 di Roberto Donati
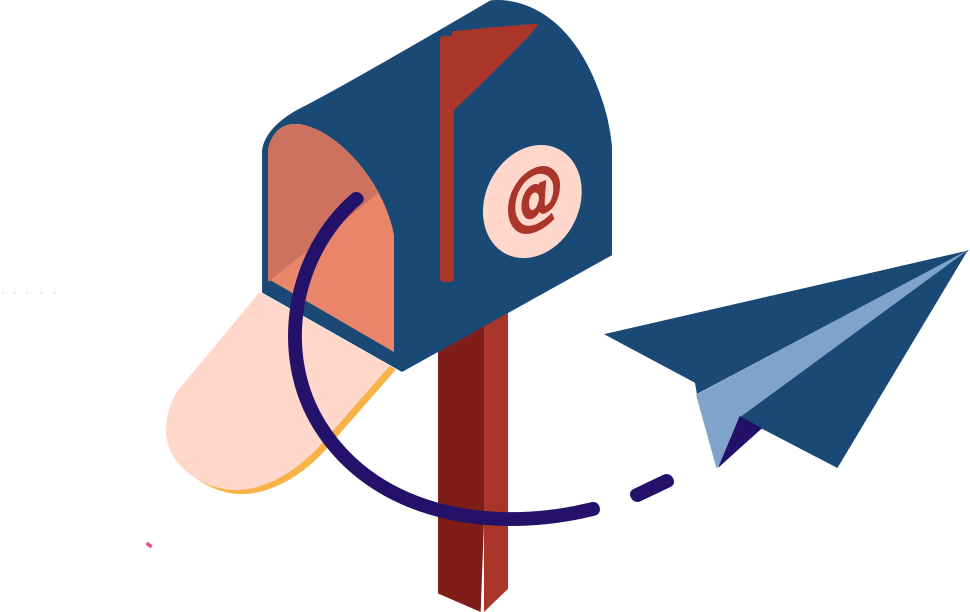
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Iscriviti Ora