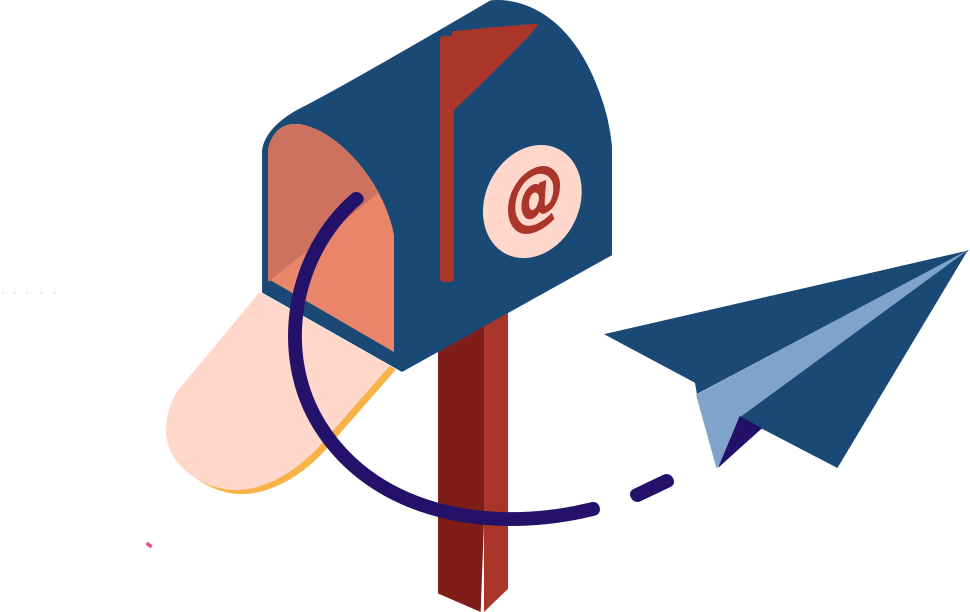FOCUS: “La nuova disciplina del partenariato pubblico-privato nel Codice dei contratti pubblici: dal contratto all’operazione economica”

Premessa
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, il legislatore ha inteso concentrare in un’unica disposizione norme che, nel d.lgs. n. 50/2016, risultavano sparse tra gli artt. 179-182. Tale scelta, oltre a razionalizzare la disciplina, ha introdotto rilevanti elementi innovativi, in linea con il diritto euro unitario e con l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale maturato sul tema.
La nuova nozione generale di PPP
Il comma 1 del nuovo articolo 174 individua il partenariato pubblico-privato (PPP) come una operazione economica e non più come un contratto tipico.
La definizione abbraccia sia il PPP contrattuale, sia il PPP istituzionale, quest’ultimo realizzato tramite la costituzione di un ente partecipato congiuntamente da pubblico e privato (comma 4), con rinvio al d.lgs. n. 175/2016 e ad altre discipline settoriali.
L’accento sulla natura di operazione economica risponde a due esigenze:
- valorizzare la complessità della fattispecie, fondata sul trasferimento del rischio operativo al privato, totale o parziale ma sempre significativo;
- sottolineare la funzionalità pubblicistica dell’istituto, finalizzato al perseguimento di interessi generali, nel rispetto dei vincoli di bilancio e mediante l’apporto di capitali e competenze private.
In questo quadro, il PPP è caratterizzato dalla lunga durata del rapporto, dal contributo finanziario significativo del privato, dall’allocazione del rischio operativo in capo a quest’ultimo e dal ruolo della parte pubblica, chiamata a definire gli obiettivi e a verificare l’attuazione del progetto, assumendosi la responsabilità di affrontare eventuali imprevisti o inefficienze.
L’ente concedente e il limite della qualificazione
Il comma 2 precisa che, per “ente concedente”, devono intendersi le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2014/23/UE.
Il comma 5 introduce una rilevante novità: la possibilità di ricorrere al PPP è riservata esclusivamente agli enti concedenti qualificati, in coerenza con il sistema di qualificazione delineato dal nuovo Codice.
Dal contratto all’operazione economica: il superamento della logica tipologica
Il legislatore ha abbandonato la concezione del PPP come contratto tipico (artt. 180-182 d.lgs. 50/2016) per adottare quella di genus contrattuale che comprende:
- concessioni;
- locazione finanziaria;
- contratto di disponibilità;
- project financing (inserito espressamente dall’art. 53, comma 1, D.lgs. 209/2024).
Il PPP può comprendere anche forme atipiche, purché rispettose dei requisiti essenziali stabiliti dal comma 1.
Tale impostazione, in linea con il “Libro Verde” della Commissione del 2004, conferisce all’istituto una flessibilità sistematica, funzionale a consentire alle amministrazioni di ricorrere a modelli contrattuali innovativi.
Le condizioni qualificanti del PPP
L’art. 174 del Codice individua quattro requisiti cumulativi:
- contratto di lungo periodo finalizzato a un risultato di interesse pubblico;
- contributo finanziario significativo del privato;
- realizzazione e gestione del progetto in capo al privato, con definizione degli obiettivi e verifica pubblica;
- trasferimento del rischio operativo al privato.
Questi elementi riflettono la logica originaria del partenariato, come delineata dal diritto UE e dal “Libro Verde”, che attribuisce al pubblico la funzione di definizione degli obiettivi e di controllo, e al privato quella di assumere il rischio di gestione economica.
Il rischio operativo come elemento indefettibile
Il rischio operativo è posto dal legislatore come tratto qualificante. Esso può riguardare sia la realizzazione dei lavori sia la gestione dei servizi. In conformità alla direttiva 2014/23/UE:
- il rischio operativo si identifica nella possibilità per il concessionario di non recuperare i propri investimenti in condizioni normali di mercato;
- esso può derivare dal lato della domanda (insufficiente utenza) o dal lato dell’offerta (mancata corrispondenza ai livelli di qualità e quantità previsti);
- il rischio deve essere significativo e non nominale, esponendo realmente il privato alle fluttuazioni del mercato.
Anche la Corte di Giustizia ha chiarito che il rischio deve intendersi come rischio di gestione economica, cioè esposizione all’alea del mercato e alla possibilità di squilibrio tra costi e ricavi (sentenze Contse, Eurawasser, Hans & Christophorus Oymanns).
L’atipicità dei PPP
Il comma 3 dell’articolo conferma il carattere aperto della disciplina: oltre ai contratti tipici già menzionati, sono ammesse forme atipiche, purché rispettino le caratteristiche funzionali del PPP e perseguano interessi pubblici meritevoli.
La relazione illustrativa sottolinea che tale apertura realizza la legge delega, la quale prevedeva l’estensione delle forme di partenariato, consentendo l’uso della capacità generale di diritto privato da parte delle amministrazioni.
Il Correttivo del Codice e la finanza di progetto
Uno dei punti centrali del Correttivo al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 209/2024) riguarda la regolamentazione del project financing, istituto che assume un ruolo strategico anche nell’attuazione del PNRR, in particolare nell’ambito delle misure relative alla concorrenza e alla riforma del settore degli appalti e delle concessioni.
La milestone “M1C1-73-quinquies Riforma 1.10” del PNRR ha posto tra i propri obiettivi la rimodulazione dell’istituto per incrementarne l’efficienza, assicurare competitività e ridurre le distorsioni concorrenziali derivanti dalla clausola di prelazione.
Il Correttivo ha introdotto tre innovazioni principali:
- rafforzamento della trasparenza nelle proposte a iniziativa privata, imponendo la pubblicazione delle informazioni rilevanti nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- semplificazione dei documenti progettuali e anticipazione dell’approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica, così da ridurre il rischio di contenzioso;
- distinzione netta tra project financing a iniziativa privata e a iniziativa pubblica.
In particolare:
- Finanza di progetto a iniziativa privata: l’ente concedente indice una procedura in due fasi, dapprima selezionando le proposte di interesse pubblico e poi bandendo la gara basata sul progetto di fattibilità tecnico-economica. È riconosciuto al promotore il diritto di prelazione sull’offerta vincente, ma in un quadro normativo più bilanciato e concorrenziale.
- Finanza di progetto a iniziativa pubblica: l’amministrazione predispone direttamente il progetto di fattibilità, anche mediante manifestazioni di interesse, e lo utilizza come base di gara per selezionare l’operatore che completerà l’intervento, apportando parte del capitale necessario.
La riforma rende così più chiaro e sistematico il quadro normativo, favorendo l’effettiva applicazione della finanza di progetto e adattandola alle esigenze dei diversi interventi, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e proporzionalità.
Considerazioni operative
Dal nuovo impianto normativo derivano alcune conseguenze rilevanti:
- non ogni rapporto con un privato rientra nel PPP: è necessario che siano presenti le caratteristiche strutturali e funzionali delineate dall’art. 174;
- soluzioni contrattuali alternative (come concessioni di diritti di superficie o altri schemi privatistici) non ricadono nella disciplina del PPP ove difetti la componente pubblicistica qualificante;
- la finanza di progetto, nella sua nuova configurazione, si pone come strumento privilegiato per attivare investimenti privati in opere pubbliche, con procedure più trasparenti e semplificate.
Conclusioni
La riforma ha ridefinito il PPP come operazione economica complessa a servizio di interessi generali, caratterizzata dal trasferimento del rischio operativo al privato e dall’apporto di risorse e competenze esterne, sotto il controllo dell’amministrazione.
La scelta del legislatore, in linea con il diritto europeo, mira a garantire maggiore efficienza e flessibilità, aprendo la strada a schemi contrattuali innovativi ma ancorati a requisiti stringenti di durata, finanziamento, gestione e rischio.
Il Correttivo ha, inoltre, rinnovato profondamente la disciplina della finanza di progetto, distinguendo tra iniziativa privata e pubblica, semplificando gli adempimenti e rafforzando la trasparenza.
Ne risulta un modello dinamico, capace di attrarre capitali e know-how privati per il perseguimento di programmi pubblici, nel rispetto dei vincoli di bilancio e con una più chiara delimitazione delle responsabilità tra pubblico e privato.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 02/09/2025
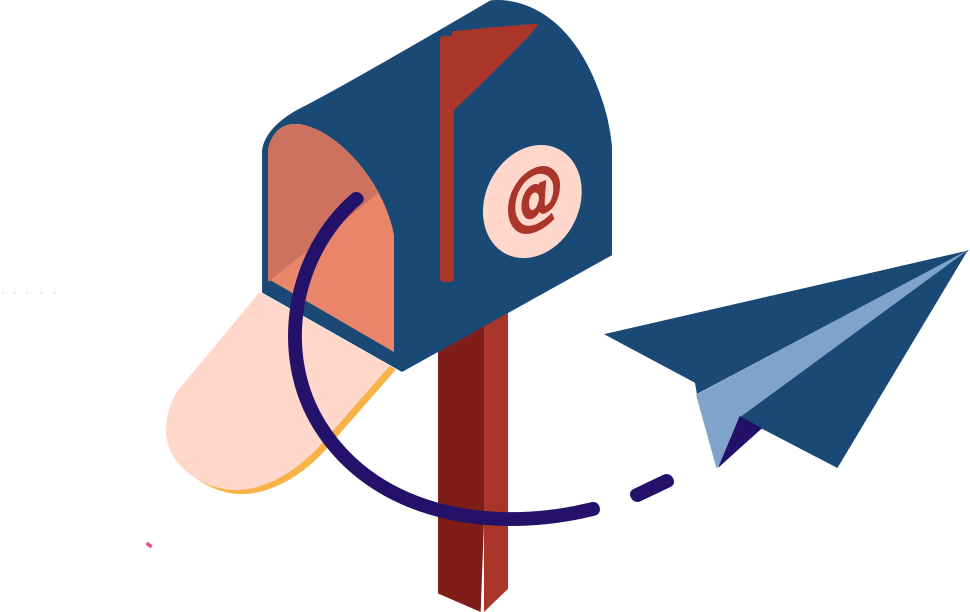
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Iscriviti Ora